
Nel lontano 1967 si aprì lamissione di evangelizzazione dei Missionari redentoristi in Madagascar e i primi a raggiungere la grande Isola,furono i rev. pp. Luigi Pentangelo e Vincenzo Sparavigna.
La bellezza del paesaggio, la luce intensa del giorno, la struggente brevità dei suoi tramonti, una natura incontaminata, straordinariamente bella e lussureggiante, ma soprattutto tanta povertà in giro, molte persone che non avevano un tetto, quasi tutte le famiglie che vivevano ogni giorno cercando un po’ di riso per sfamare i propri figli e se stessi, le grandi carenze igieniche, i moltissimi bambini spesso magri ed ammalati, l’analfabetismo quasi al 100%: ponevano le basi entusiasmanti per rimanere in quell’isola; animarono le azioni e l’ardore apostolico di Pentangelo e Sparavigna per aiutare questo popolo; fornirono le motivazioni teologiche ai due sacerdoti per impegnarsi a convertire ed evangelizzare questa gente; ispirarono la loro attività missionaria alla sua fonte primordiale che era ed è la carità di Dio secondo il dettato della Gaudium et Spes ed in particolare del Decreto Ad Gentes: “La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa deriva la propria origine” (Cap. I).
Per queste motivazioni, negli anni a seguire, i Redentoristi si innamorarono di questa nazione, tanto che altri missionari hanno raggiunto il Madagascar. Io fui il quarto Padre che nel mese di dicembre del 1969 raggiunse l’isola, unendomi ai primi due padri Luigi Pentangelo e Vincenzo Sparavigna e successivamente a padre Giovanni Battaglia.
Veramente, avevo sempre desiderato di andare come missionario in Argentina, ma, in quell’anno, la Congregazione non era ancora pronta per aprire Missioni nella nazione sud americana; per questo, il Padre Provinciale mi chiese se ero disponibile a partire per il Madagascar. All’epoca avevo 38 anni e nonostante venisse meno il mio sogno, la mia vocazione missionaria mi spinse ad accettare l’invito, vedendo, nell’insieme, i piani della Provvidenza per il mio futuro di missionario. Prima di partire, non conoscendo né il malgascio né il francese, seguii un corso accelerato di lingua francese a Napoli, tenuto conto che questa era la seconda lingua parlata nella grande isola e che mi sarebbe servita per poter comunicare ed avvicinare la popolazione.
Nel dicembre 1969, con il solo biglietto di andata e con pochi soldi in tasca, partii per il Madagascar. Il viaggio fu tranquillo, volo regolare per tutta la lunghissima rotta Italia, Africa, Madagascar. Non così per il volo interno, per raggiungere i confratelli che si trovavano a Diego-Suarez (o Antsiranana), città capoluogo della regione Diana, ubicata nell’estremo nord del Madagascar. Giunto all’aeroporto della capitale, presi un aereo interno con destinazione Diego-Suarez.
A differenza dell’aereo del volo intercontinentale, gli aerei per i voli interni erano ad eliche ed un po’ obsoleti. Arrivati nelle vicinanze della città, l’aereo iniziò a sobbalzare, a salire e scendere, sembrava un veicolo senza pilota, con virate strette ed abbassamenti rapidi che sembrava di lì a poco di precipitare; ebbi molta paura, fui quasi preso dal panico, pensai che tutto sarebbe finito prima ancora di iniziare; mi raccomandai al Signore affinché tutto fosse finito nel momento dell’impatto con il suolo. Atterrammo normalmente, non vi era mai stata un’avaria dell’aereo; dopo seppi che era il modo di pilotare dei piloti malgasci, meno male.
All’aeroporto i Padri mi aspettavano; fui accolto con tanta gioia e lietezza, con abbracci di benvenuto. Il popolo, avvertito della mia venuta, mi aspettò fino a tarda sera presso la Missione.
Poi, non vedendo arrivare Sparavigna e Pentangelo con il nuovo sacerdote, rientrarono nelle loro capanne.
Durante la cena, ai due Padri raccontai l’accaduto dell’aereo “impazzito” su quella collina che circondava la città, confessando che avevo avuto molta paura, che tutto sarebbe finito in quella terra sconosciuta, così lontana dall’Italia, dai miei affetti… Ma, loro avevano già parecchia esperienza in questo ed in particolare in quella nazione primitiva rispetto alla vita di noi europei e tutti si misero a ridere per quello che avevo vissuto, coinvolgendo anche me in quello stato d’animo di ilarità spontanea dei presenti.
Andai a dormire, non vedevo l’ora di stendermi e riposare in un letto. Ero molto stanco per il lungo viaggio, per il cambiamento di clima e di temperature, ero passato dalla stagione invernale dell’Italia a quella estiva e per giunta ad un clima ed una temperatura tropicale. La prima notte fu un calvario: il letto scomodo, il ronzio fastidioso degli insetti attorno a me, le punture strazianti di continue ed insaziabili zanzare, il buio nero della stanza, la nuova aria del luogo, tutto questo mi tenne sveglio per quasi l’intera notte, con un aumento della stanchezza fisica. Ai primi bagliori dell’alba, prostrato mentalmente e con le membra contratte per la notte trascorsa, mi alzai e, dopo essermi vestito, iniziai a recitare il breviario camminando lungo la veranda della Casa missionaria.
Preso dalla lettura dei salmi, delle preghiere, non mi accorsi che nel piazzale antistante la veranda si era radunata una piccola folla formata sia da persone adulte che da bambini, tanti bambini, i cui sguardi erano rivolti verso di me; chi batteva le mani, chi con le braccia alzate le agitava, chi sventolava fiori che aveva in mano e tutti gridavano: “Mbolasare Mompera” (“Salute, Padre!”).
La stanchezza accumulata, la notte trascorsa quasi senza riposare, i nervi a fior di pelle, mi fecero interpretare quei gesti e quelle parole, non conoscendo la lingua malgascia, come degli insulti, come l’equivalente di canzonatura italiana “scemo, scemo!”. Non avendo la calma necessaria, risposi in malo modo e minacciai di scendere e, addirittura, di attaccar briga. Per fortuna, sentendo il canto festoso dei malgasci, le parole di gioia rivolte verso di me, i saluti di benvenuto al nuovo sacerdote di quella piccola folla, padre Pentangelo, padre Sparavigna e padre Battaglia si erano affacciati per godersi lo spettacolo.
La mia reazione, tanto sbagliata quanto ingrata verso quella gente, fu immediatamente corretta da uno dei Padri, il quale mi fece intendere quanto stava succedendo: le persone lì radunate stavano manifestando la loro gioia per il nuovo Padre, che lo stavano salutando con canti e danze, melodie e ritmi per il nuovo arrivato alla Missione. Rimasto per un attimo interdetto, passando da uno stato di rabbia a quello di gioia, con spirito colmo di inaspettata felicità per quella accoglienza che mi era stata riservata, scesi giù non più con animo belligerante verso quei primitivi, ma con cuore sereno ed accogliente verso quei fratelli malgasci e li abbracciai tutti, donne, uomini, bambini.

La prima missione che il Vescovo di Diego affidò ai Padri Redentoristi al loro arrivo fu Tanambao, un agglomerato di capanne nella parte nord della città di Antsiranana (Diego-Suarez).
Dopo qualche giorno, padre Battaglia mi portò nella brousse per celebrare la S. Messa e per iniziare la catechesi verso gli abitanti del luogo.
Era la prima volta che uscivo dalla Casa missionaria. Lungo il tragitto passammo per il centro della città. Diego-Suarez era una città piacevole; già allora era la più grande città settentrionale del Madagascar ed aveva il secondo porto più esteso del paese; il nome, infatti, Antsiranana significa, nella lingua locale, “porto” a testimonianza dell’importanza del porto nel paese. Caserme, arsenali militari nel porto, strade rettilinee e parallele, edifici coloniali erano le testimonianze della passata presenza francese nella città e nella regione circostante, iniziata nel 1883 e finita nel giugno del 1960 quando il Madagascar divenne ufficialmente una repubblica indipendente.
Lasciato il centro della città, lungo il viaggio notai tante piccole casette fatte di pali di legno e chiuse con paglia e lamiere. Era la prima volta che vedevo quelle capanne, le quali sembravano più ricoveri di animali che altro. Grande fu la mia meraviglia quando il confratello che guidava l’auto mi disse che quelle capanne – che io avevo scambiato per allevamenti di maiali – erano le abitazioni della gente del posto: lì mangiavano, lì dormivano, lì si riparavano dal sole e dalle piogge dei monsoni, lì si svolgeva la vita familiare, in uno spazio di circa 15 mq. Da quel giorno imparai a conoscere l’estrema povertà del popolo malgascio, in quale ambiente mi trovavo.
La gente aveva bisogno di tutto, la povertà si vedeva in ogni luogo, in ogni posto e mi disperavo di non riuscire a dialogare con loro perché non conoscevo la loro lingua. I Padri non avevano tempo da dedicarmi, presi dalle loro quotidiane uscite dalla Casa che li teneva impegnati tutto il giorno nella loro opera missionaria di evangelizzazione. Non vi erano libri, testi, dizionari per poter da solo imparare la lingua e così trovai un adolescente che conosceva il francese e con lui iniziai a dialogare, tra mille difficoltà, per imparare il malgascio. Ci vollero mesi e mesi per imparare le prime nozioni elementari della lingua. Conosciuti i primi rudimenti della stessa, iniziai ad uscire e a visitare i villaggi per portare la Parola del Vangelo.
Quando arrivavo in un villaggio, era sempre lo stesso rituale e, data la poca cultura dei locali, questi dicevano quasi sempre le stesse parole verso il missionario, per cui, mi fu facile capire le loro espressioni linguistiche e a prendere familiarità nel rispondere aggiustando, volta per volta, sia il linguaggio che la dizione. Iniziai così a pensare in malgascio, a preparare un discorsetto, a rispondere con frasi fatte ai catechisti, a rispondere ai saluti della gente quando arrivavo in un villaggio.
Dopo qualche anno, fui trasferito presso la Casa missionaria di Vohemar, distante circa 200 km da Antsiranana, sulla costa est, paese di circa 10.000 abitanti. A differenza della grande città di Diego-Suarez (Antsiranana), a Vohemar vi erano molti villaggi da visitare. Spesso, stavo fuori dalla Missione circa un mese, passando da un villaggio all’altro per amministrare i sacramenti: battesimi, confessioni, comunioni, matrimoni.
L’entusiasmo di portare la Parola del Vangelo a quella gente, la festa con la quale gli abitanti mi accoglievano, l’attenzione che ponevano nell’ascoltare la S. Messa, l’aumento delle persone che si convertivano, alleviavano la stanchezza del viaggio compiuto a piedi da un luogo all’altro, delle notti trascorse sul tavolato duro del pavimento della capanna per dormire, dei frugali pasti di riso che gli abitanti offrivano da mangiare a me ed ai catechisti che mi accompagnavano in quei lunghi giri per i villaggi, distanti anche una cinquantina di chilometri ed oltre da Vohemar.
Una mattina, prima di partire da un sperduto villaggio estremamente povero, la gente, non avendo riso da offrirmi per mangiare sia per colazione che lungo il nuovo tragitto per andare in un altro villaggio, mi diede cinque uova, raccomandandomi di stare attento durante il cammino per evitare che si rompessero. Per paura che si rompessero nel bagaglio, trasportato a spalle dai miei collaboratori catechisti, davanti alla folla che si era radunata per salutarmi, presi le uova e una dopo l’altra, dopo aver praticato un foro su una estremità, ne bevvi il contenuto. Grande fu lo stupore degli indigeni, perché non conoscevano questa pratica. In seguito, nel corso della visita successiva allo stesso villaggio, seppi che anche loro avevano iniziato a bere le uova come il “Monpera” (“Padre”, ndr).
Il fluire dei ricordi che comunicano non epidermiche sensazioni,
ma immagini impresse nel cuore nel corso di tanti viaggi compiuti di villaggio in villaggio, è un’intensa esperienza spirituale che mi accompagna costantemente nella mia vita quotidiana, ancora oggi.
Da Vohemar il Vescovo mi volle ad Ampanefena, un grande villaggio interno di un migliaio di anime, distante una settantina di chilometri da Vohemar; esso era situato lungo la strada che unisce Vohemar a Sambava. Le abitazioni erano quasi tutte capanne, vi era una diffusa povertà nel villaggio, moltissimi, adulti e bambini, erano denutriti, la mortalità infantile era altissima, in pochi riuscivano a superare i due anni di vita. In alcune parti del villaggio la vita era rimasta allo stato primitivo, le donne camminavano coprendosi dal bacino in giù mentre la restante parte del corpo era esposta al sole senza provare alcuna soggezione agli sguardi altrui. Più si andava nei villaggi dell’entroterra e più si notava che le condizioni di vita erano rimaste quasi immutate nel tempo: riti magici, feticci, venerazione dei morti, il capo “tribù”, lo sciamano…
Era un ambiente difficile, arretrato, quasi impenetrabile ed impermeabile alle nozioni più elementari di civiltà. Non c’era bisogno di aprire gli occhi per riconoscere chi era il mio prossimo: era tutta quella gente, quel popolo era il mio prossimo ed io, missionario in quel luogo, avevo il privilegio di servire Cristo in quelle persone abbandonate, soccombenti, per molti, dei reietti. Talvolta, davanti a questo immane compito di evangelizzazione che mi attendeva, mi assaliva lo sconforto perché non avevo mezzi a disposizione per alleviare le loro esigenze; non avevo disponibilità economiche per sfamarle, per distribuire medicinali; non avevo né aiuto né collaborazione di altri missionari perché ero solo.
Ma lo sconforto veniva ricacciato perché tutto questo sarebbe stata un’occasione per andare alle radici del senso del mio esistere e del mio peregrinare di missionario: Gesù non vuole che rinunciamo, che restiamo rinchiusi in noi stessi, Egli ci invita ad uscire, a buttarci, a realizzare il suo sogno, a mettere al centro le esigenze del Vangelo; dovevo spendermi concretamente in questa missione, essere il servo di questo popolo che il Signore mi aveva fatto incontrare: dovevo realizzare il sogno di Dio.
Arrivato ad Ampanefena, andai ad alloggiare presso la Casa
Missionaria dei Padri della Congregazione dello Spirito Santo. Non so per quali motivi, gli spiritani avevano lasciato questa Casa, lasciando, ancora per un anno, un loro confratello, padre Crespel. Data l’età di quest’ultimo, 80 anni circa, le uscite per andare ai vari villaggi le facevo da solo o in compagnia di qualche catechista che mi aiutava nel portare il bagaglio. Tuttavia, la presenza di padre Crespel nella Missione mi fu molto utile perché imparai molto bene sia il francese che il malgascio, tanto da pensare e parlare nelle due lingue, abbandonando quasi del tutto la mia lingua madre. Le cose si complicarono dopo la partenza di p. Crespel perché dovetti addossarmi anche il lavoro per il buon funzionamento della Missione.
Il Madagascar, trovandosi nell’emisfero meridionale, ha le stagioni invertite rispetto all’Europa, per intenderci, da noi il 21 dicembre è il solstizio d’inverno, mentre in Madagascar è il solstizio d’estate. L’isola conosce una stagione piovosa, da novembre a marzo, e una stagione secca, da aprile ad ottobre. La costa orientale è quella maggiormente esposta ai venti alisei ed è, quindi, la parte più piovosa dell’isola. Durante le forti piogge, la Missione di Ampanefena diventava un lago e, data la natura del terreno, l’acqua ristagnava per molti giorni anche se non pioveva, rendendo impraticabile il sito e di conseguenza anche l’affluire della gente verso la Missione ed in particolare la frequentazione della Chiesa per le funzioni religiose svolte di domenica.
Per quasi tutto il periodo, da novembre a marzo, l’attività liturgica e catechistica all’interno della Missione si riduceva quasi a zero. Quel lago d’acqua rimaneva così per settimane, molte volte si vedevano rane nuotare, saltare in quell’acqua, mancavano solo i pesci… magari, almeno il pescato l’avrei offerto ai locali; ma io non ero pescatore di pesci, io volevo essere pescatore di anime, di uomini come disse Gesù a Simone al lago di Genèsaret. Non potevo restare inoperoso per così lungo tempo, dovevo pensare ad un sogno, dovevo pensare alla grande per poter continuare la mia opera missionaria senza interruzione di sorta. E così pensai di spostare la Missione da quel luogo in un altro posizionato più in alto sicché le acque di pioggia potessero scorrere ed allontanarsi dalla struttura della Chiesa, dall’abitazione in cui vivevo, dalla Missione.
Avevo bisogno dell’autorizzazione del Vescovo il quale acconsentì a condizione di non sperare sul suo aiuto perché non aveva risorse finanziare per aiutarmi in quel mio progetto. Ero tutto infervorato, sapevo che il Signore non mi avrebbe abbandonato e sperai tanto nel Suo aiuto, di aprirmi le strade per realizzare quel progetto, di essere testimone per far conoscere la grandezza della Sua misericordia verso quella gente affinché potessero incontrarLo ogni domenica nel corso della celebrazione della S. Messa e tutte le sere che le anime dei convertiti lo volevano pregare. Dovevo fare tutto io, ero sicuro che ce l’avrei fatta, avevo il Signore con me…
Nel 1975 tornai in Italia con lo scopo precipuo di fare una raccolta
in danaro per la realizzazione della nuova Missione ad Ampanefena. Mancavo da sei anni dalla mia casa, dai miei familiari, dai miei confratelli redentoristi. L’entusiasmo che avevo nel cuore coinvolgeva gli amici che incontravo; il fervore con cui parlavo sollecitava l’interesse delle famiglie; il sentimento di amore verso quel popolo che avevo lasciato laggiù raggiunse i cuori delle persone. Tanta fu la generosità di chi aveva ascoltato le mie parole, di coloro che avevano aderito al mio progetto, di tanti uomini e donne che avevano visto in questo povero missionario portare il fuoco della missione che mi era stata affidata. Raccolsi oltre undici milioni di vecchie Lire. Con quella somma si potevano acquistare in Italia quasi tre appartamenti di cinque stanze, gli stessi oggi valgono oltre 400.000 euro. Dunque, una fortuna. Per tutto questo, vidi che Gesù mi era stato accanto, il Signore aveva esaudito quanto richiesto, il sogno di Dio si stava realizzando.
Con quei soldi edificai la nuova Missione. Fu costruita una nuova Chiesa, con maggiore spazio al fine di accogliere un maggior numero di fedeli. Ci fu una grande festa quando fu inaugurata, con partecipazione di tanti fedeli, di tanta gente convertita. Di domenica, la Casa del Signore era piena, tutti i cattolici di Ampanefena partecipavano alla celebrazione, quasi tutti facevano la comunione; suoni e ritmi, canti e danze eseguite dai fedeli al proprio posto rendevano gloria al Signore: la Chiesa di Dio era in cammino… La Missione era frequentata da molti bambini e adolescenti, parecchi di loro dimostravano un certo attaccamento, un interesse particolare alle funzioni liturgiche, una partecipazione più attiva degli altri. Fu questo un altro segno che mi spinse a formare un piccolo seminario per queste piccole anime, per far crescere in loro la Fede che sempre più essi manifestavano nelle azioni di collaborazione e di assistenza alle celebrazioni eucaristiche, liturgiche e catechistiche.
Feci costruire una casa in cemento, accanto a quella delle abitazioni dei Sacerdoti, per accogliere nove bambini: era, a tutti gli effetti, un piccolo seminario. Dunque, ad Ampanefena nacque il primo Seminario realizzato dai Redentoristi nel Madagascar. Questa iniziativa fu il germe catalizzatore per realizzare nuovi gruppi di seminaristi o aspiranti tali nelle varie Case che in seguito furono realizzate: Antananarivo, Andranokobaka, Vohemar…
Un giorno, era l’anno 1981, dovetti recarmi a Sambava per fare delle commissioni e per ritirare del denaro per pagare gli operai impiegati alla costruzione della nuova Missione ad Ampanefena. Il tragitto l’avevo compiuto con una moto usata che avevo comprato qualche anno prima per spostarmi più velocemente da un villaggio all’altro ed allargare le visite ad altri villaggi sperduti e più lontani dalla Missione che altrimenti non avrei potuto raggiungere. Sulla strada del ritorno, per la presenza di sassolini in una curva sul manto stradale, le ruote della moto slittarono, persi l’equilibrio e caddi a terra.
In quel periodo, una impresa italiana stava costruendo ed asfaltando le prime strade locali, tra le quali quella che collegava Vohemar a Sambava e questa a Andapa.
A seguito della mia caduta dal motorino, persi i sensi e rimasi a terra. Per fortuna, passarono di lì alcuni operai della ditta che avevo conosciuto nel corso della loro partecipazione alla S. Messa alla Missione. Si avvicinarono e visto che non rinvenivo, mi raccolsero e mi portarono al più vicino ospedale. In seguito, seppi che nel cadere avevo battuto la testa, riportando un trauma cranico. Come un tam tam che risuona nella foresta, la notizia del mio incidente rimbalzò da un villaggio all’altro, tutti seppero delle mie gravi condizioni di salute e che, da oltre un giorno, non avevo ripreso conoscenza. Come sempre succede in questi casi, qualcuno mi dava per spacciato, per altri ero già morto.
In seguito ho saputo che in tanti villaggi, la gente del posto che mi conosceva, andò nelle chiese a pregare ed invocare il Signore per la salute di “Mompere Jean”. Molti vennero presso la struttura sanitaria dove ero ricoverato. Tutti volevano notizie circa le mie condizioni. Pregavano mediante i loro canti, il loro attaccamento si manifestava mediante danze e canti religiosi. Passò un altro giorno e le mie condizioni erano stazionarie. Il trauma commotivo cerebrale, che avevo riportato battendo la testa a terra, continuava con la perdita di conoscenza. Il terzo giorno ripresi conoscenza, uscii da quel torpore; aprendo gli occhi mi meravigliai di stare in quel posto; qualche attimo prima ero in sella alla moto, come mai ero in un letto circondato da personale sanitario?

Il trauma cranico aveva avuto, tra l’altro, la
conseguenza di farmi perdere la memoria, non ricordavo più nulla da quando avevo battuto la testa. Da quanti giorni ero in quel luogo di cura, in quel letto, in quelle condizioni?
Pur sforzandomi, la mia mente era vuota, non avevo alcuna cognizione del tempo. Poco alla volta, i ricordi, dapprima distorti, ineguali, come una fascia costiera con sporgenze e rientranze, iniziarono a comporsi, a definirsi. Compresi quanto mi era accaduto, il pericolo a cui ero scampato, la morte certa se non fossi stato soccorso da quegli operai italiani. Strano, però, mentre “dormivo” vedevo il volto di s. Gerardo, era continuamente accanto a me, spesse volte i nostri sguardi si incrociavano, era una gioia immensa per me vederlo, un senso di sollievo pervadeva tutto il mio cuore, era lì, nella stanza, io e lui, mi guardava, mi parlava, mi faceva cenno di alzarmi… aprii gli occhi e… ripresi i sensi: ero uscito dal coma. Sono stato sempre un devoto di s. Gerardo e da quel momento lo fui ancora di più. Era stato Lui a salvarmi.
L’incidente era avvenuto poco distante dal villaggio di Ampodypont, ad una ventina di chilometri dalla Missione di Ampanefena. Per ringraziare s. Gerardo, per il suo preziosissimo aiuto, decisi di realizzare una piccola chiesa nel villaggio di Ampodoupont, intitolandola al Santo redentorista. Era una chiesetta semplice, fatta di legno e di lamiera, avendo come pavimento la nuda terra.
Successivamente, le fatiche, la stanchezza accumulata negli anni, gli sforzi a cui mi ero sottoposto nel raggiungere i vari villaggi della Missione, ma principalmente i postumi dell’incidente con la moto, resero instabile il mio stato di salute, le mie forze si indebolirono, andavo sempre più a peggiorare, ero stanco nel fisico e nella mente, avevo continui mal di testa. Alla fine, dietro consiglio dei dottori a cui ricorsi per la mia debilitazione, nel 1982 lasciai la Missione, gli amati villaggi, la straordinaria gente di quei luoghi, i seminaristi, la meravigliosa terra del Madagascar e tornai in Italia per curarmi. Fu un doloroso distacco dalle cose e dalle persone. Pur senza mai cedere alla disperazione per quella partenza forzata, i miei pensieri erano sorretti da una grande fiducia in Dio, per le opere che avevo compiuto grazie al Suo aiuto in tutti gli anni che ero stato Suo missionario in questa terra primitiva, evangelizzando e catechizzando nel Suo nome, portando il Vangelo in villaggi remoti, illuminando i cuori di tante persone con la grazia di Dio. Come Lucia di manzoniana memoria, il mio pensiero, la mia speranza era quella che un giorno sarei tornato …
Alcuni anni fa, a seguito di una sommatoria di tanti pensieri,
ricordi, affetti lasciati, voglia di rivedere quei luoghi che mi avevano visto protagonista della vita Missionaria, decisi di (ri)tornare nel Madagascar, ad Ampanefena, spinto anche dal desiderio di vedere la chiesetta di Ampodoupont ricostruita dopo che la prima era stata distrutta dalla furia di un monsone.
Ero un semplice sacerdote diocesano, ero uscito dalla Congregazione. Quando si sparse la notizia del mio ritorno alla Missione, tanta gente era lì ad aspettarmi, c’era una gioia nell’aria, una festa nei cuori delle persone, un tripudio di canti e danze che il popolo manifestava per il mio ritorno, applausi tutti dedicati al loro Missionario. La chiesa non era abbastanza grande per contenere tutto quel popolo di Dio venuto anche da altri villaggi, fu la Messa più bella da me celebrata.
La stessa cosa si ripeté quando andai ad Ampodoupont. La gente mi venne incontro all’inizio del villaggio. Tutti mi volevano vedere, salutare, stringere la mano, tutti erano sorridenti. Accompagnato da questa folla festosa, ci avviammo verso la chiesetta ricostruita. La trovai ben tenuta e, con mia grande meraviglia, vi era una statua di S. Gerardo! Seppi in seguito che questa statua era stata portata dal Superiore Provinciale, padre De Luca, nel corso di una sua visita pastorale alle Missioni in Madagascar.
Dopo la S. Messa, alcuni di loro mi chiesero se era possibile ingrandire la chiesetta, dal momento che la stessa veniva frequentata anche da fedeli provenienti da altri villaggi, in modo particolare il 16 di ogni mese in onore di S. Gerardo.
Una grande gioia scosse il mio animo, la grande devozione che avevo per il Santo era stata trasmessa ed allargata ai fedeli di quella terra. Non ci pensai due volte e promisi che sarebbe stata costruita una nuova chiesa in muratura da essere più robusta e sostenere la furia dei monsoni. Dopo poco, mi misi in contatto con un tecnico e costruttore edile malgascio chiedendogli di fare un progetto per una nuova chiesa e presentarmi un preventivo circa i costi di realizzazione. Alla fine, fu approvato un progetto per una struttura in cemento armato avente le dimensioni L = 25 mt e larga 10 mt, con frontone all’entrata ed un campanile a forma ottagonale sormontato da 4 croci. Lungo le due pareti vi erano quattro finestre tali da far entrare quanta più luce possibile nella nuova casa del Signore. Dietro all’altare vi era una piccola sacrestia ed i servizi igienici. Fu realizzato anche un pozzo per l’acqua potabile profondo quasi venti metri, pozzo a disposizione della gente che voleva attingere acqua senza percorrere più chilometri a piedi per andare al fiume e rifornirsi di acqua. Il preventivo fissato era di € 50.000, con un anticipo di € 10.000, dovendo il costruttore portare il materiale dalla capitale, Antananarivo, visto che in tutta la regione non vi era il materiale adatto per eseguire la costruzione in muratura.
Dopo poco più di un anno, la chiesa fu terminata. Ora vi era la necessità di abbellirla e così comprai tutto quello che era necessario ed utile per la nuova chiesa, inviando, tra l’altro, un grande Crocifisso, un grande quadro della Madonna di Pompei, le varie Stazioni della Via Crucis …
Insieme al Superiore Provinciale CSSR p. Davide Perdonò; al Superiore Regionale del Madagascar p. Roger Robbia; al Superiore di Vohemar p. Michel Tombofeno ed al clero della Missione; al Superiore di Ampanefena p. Jorge Ortiz Guerrero ed il clero della Missione p. Brice Narivelo e p. Clovis Jean Rafidison; al maestro dei novizi della Missione di Andranokobaka p. Vahiny Venance; insieme alle organizzazioni cattoliche dei villaggi che negli anni della mia vita missionaria avevo evangelizzato e di altri villaggi, il 6 luglio del 2014, con la celebrazione di una Messa solenne, la nuova Chiesa fu benedetta e consacrata.
Più di un migliaio di persone erano presenti all’evento. Quando intorno alle 9.30 del mattino arrivammo ad Ampodoupont, già all’incrocio della strada 5A (Ambilobe – Vohemar – Sambava) con il villaggio era radunata una piccola folla che attendeva il nostro arrivo; bloccarono il corteo, tutti volevano salutare i sacerdoti, tutti volevano esprimere la loro gioia con sorrisi, canti, strette di mano e quando iniziammo a procedere verso il centro del villaggio, quella gente ci seguiva, tenendo il passo anzi la corsa per stare dietro alle auto. Sul sentiero principale passammo tra due ali di gente che con striscioni di benvenuto e con bandierine in mano di colore giallo e bianco, simbolo del Vaticano, con fiori, palme e le braccia alzate ci accoglievano manifestando la loro gioia per quel giorno così importante per loro e per tutto il villaggio.
Il clima era di grande festa, l’aria era attraversata da canti malgasci; su quei volti vi era riconoscenza per quello che era stato realizzato nel loro villaggio; sui loro volti vi era la gioia, la meraviglia dell’uomo; la mia azione, la costruzione della nuova chiesa, aveva avuto l’effetto coinvolgente di quel popolo riscattandolo dall’anonimato, dall’emarginazione, dal silenzio, elevandolo a popolo di Dio, a seguaci di Cristo, gli ultimi che erano diventati i primi, seppure per un giorno; lo Spirito di Dio, che è Amore e Misericordia, soffiava nel cuore di quella gente rendendolo felice nell’anima; testimoniavano la loro Fede, il loro Amore, la loro Vita a tutti noi sacerdoti presenti quella mattina. Arrivati davanti all’abitazione del responsabile della comunità cattolica di Ampodoupont, una modesta casa in muratura, la folla era più numerosa, e già da quando fummo in vista, passata la curva, fummo accolti da una grande ovazione di applausi, da canti, un fitto agitarsi di mani sollevate, rimanendo ai bordi del grande sentiero, una strada in terra battuta priva quasi di ogni manutenzione. Il mio sguardo si fermava su quella gente festosa, sui tanti bambini, ragazzi, giovani, adulti, vestiti quasi tutti con pantaloni e camicia quest’ultimi, le ragazze quasi tutte con gonna corta e dai vistosi colori e camicetta bianca o dai colori vivaci, i ragazzi per lo più con i pantaloncini corti, le donne con gonne e camicette, altre avvolte in mantelli colorati, alcune con collane d’oro, altre con lapislazzuli, pietre colorate, infilati con lo spago o in fili di argento o semplice filo di ferro, quasi tutti avevano indossati gli abiti della “domenica”, delle grandi occasioni: era un popolo in festa.
Era un mattino pieno di sole, il cielo azzurro, i mille colori dei vestiti dei fedeli ornavano il cammino del popolo di Dio verso quel sogno che si era tramutato in realtà: avere una chiesa, un luogo non più soggetto alle intemperie, un posto per raccogliersi in silenzio e poter pregare, rivolgere lo sguardo ed incontrare gli occhi di Gesù del grande Crocifisso, chiedere l’intercessione della Vergine potendo guardare l’immagine della Madonna di Pompei, poter rivivere le sofferenze, la passione di Gesù e la Sua morte in croce nei vari riquadri delle Stazioni della Via Crucis, offrire il proprio cuore al Santo che più conoscevano, a s. Gerardo, realizzava tutto ciò che quel popolo potesse desiderare. Era una vera e bella chiesa.
Dopo i saluti di benvenuto delle “autorità locali”, leggasi capo
villaggio ovvero del responsabile cattolico del posto, ci avviammo verso il poggio su cui era stata costruita la chiesa. Una lunga processione di fedeli si incamminò verso la nuova chiesa, accompagnata da suoni e canti. Noi sacerdoti eravamo davanti al corteo. Arrivati sul punto più alto della salita, prima di girare a destra per accedere, dopo poco decine di metri, nello spazio antistante la chiesa, mi girai indietro e vidi tanta gente che ci seguiva, una lunga processione, un popolo in cammino verso la Casa del Signore. Nel vedere tutto questo, tanti pensieri passarono nella mia mente, tante riflessioni illuminarono la mia anima, tante emozioni esplosero nel mio cuore. Mi sentivo strumento di Dio, apostolo del Signore: ero arrivato in quel luogo remoto, in quell’angolo sperduto del Madagascar per far conoscere e portare il messaggio dell’Amore, della Pace, della Fede in Lui e quella visione del corteo era la prova dell’azione di Dio che aveva operato in me. La chiesa si riempì, era stracolma; la maggior parte delle persone seguì la S. Messa sul piazzale antistante la chiesa. Il Vescovo, nel corso della celebrazione eucaristica, consacrò la nuova chiesa. Il sogno del Signore si era realizzato.
Alla fine della celebrazione, in fondo alla chiesa, sul lato sinistro
per chi entra, fu scoperta una targa in ricordo del benefattore: il mio nome sarebbe rimasto a ricordo perenne nei cuori di quella gente e delle future generazioni.
Come nelle migliori e più sentite feste dei locali, per quella occasione fu ucciso un bue.
L’anno successivo, la chiesa di s. Gerardo ad Ampodoupont è stata allargata con la costruzione dell’abitazione per i Padri.
La Casa del Signore, la chiesa di Ampodoupont è stata visitata da sua Ecc.za Rev.ma l’arcivescovo Benjamin Marc Balthason Ramaroson, Vescovo Metropolitano di Antsiranana, il quale ha molto apprezzato l’opera realizzata ma, principalmente, l’azione di trasformazione dei fedeli del villaggio operata dalla presenza della chiesa con una partecipazione ai riti eucaristici e alla vita catechistica che aumenta sempre di più, con gente che viene anche da altri villaggi per vedere la chiesa, per pregare s. Gerardo, per diventare sempre di più cattolici impegnati nella divulgazione ed annunciazione del Vangelo. Per questi motivi, sua Ecc.za mi ha inviato una lettera di ringraziamento per le opere realizzate e per il fervore cristiano suscitato nei cuori di tanti fedeli, allegando una pergamena, con la foto della chiesa su di essa, congratulandosi per tutto quello che avevo fatto per il popolo di Dio di quei villaggi ed annunciandomi che la chiesa è stata dichiarata Santuario in onore di s. Gerardo. Quanta gioia ha invaso il mio cuore nel leggere la lettera, la pergamena, e più di tutto, che laggiù, in terra malgascia vi è un Santuario dedicato a s. Gerardo
Non passa un giorno, nel corso delle mie preghiere, durante le celebrazioni eucaristiche, nei momenti in cui i ricordi si affollano e si affacciano nella mia mente che il mio pensiero non va verso quei fedeli, quelle terre, quei villaggi che mi hanno visto impegnare la mia vita come missionario…
Per questo mio attaccamento, per questi ricordi così presenti e così forti, quest’anno, 2017, in occasione del cinquantesimo della fondazione della Missione Redentorista nel Madagascar, impegnerò tutte le mie residue forze per ritornare in quei luoghi, per rivedere di nuovo la Chiesa di s. Gerardo completata.
Voglio sperare ed augurarmi che con la presenza di s. Gerardo, il popolo possa convertirsi sempre di più al Signore e diventare autentico devoto di s. Gerardo e che i sacerdoti, all’ombra del Santo possano diventare più numerosi e soprattutto grandi devoti di questo grande Santo della carità.
Corbara
don Giovanni Padovano




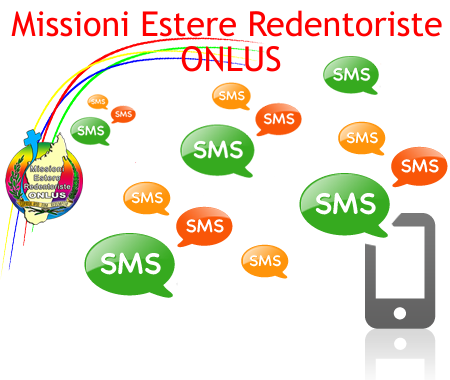
Lascia un commento